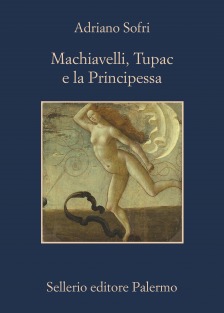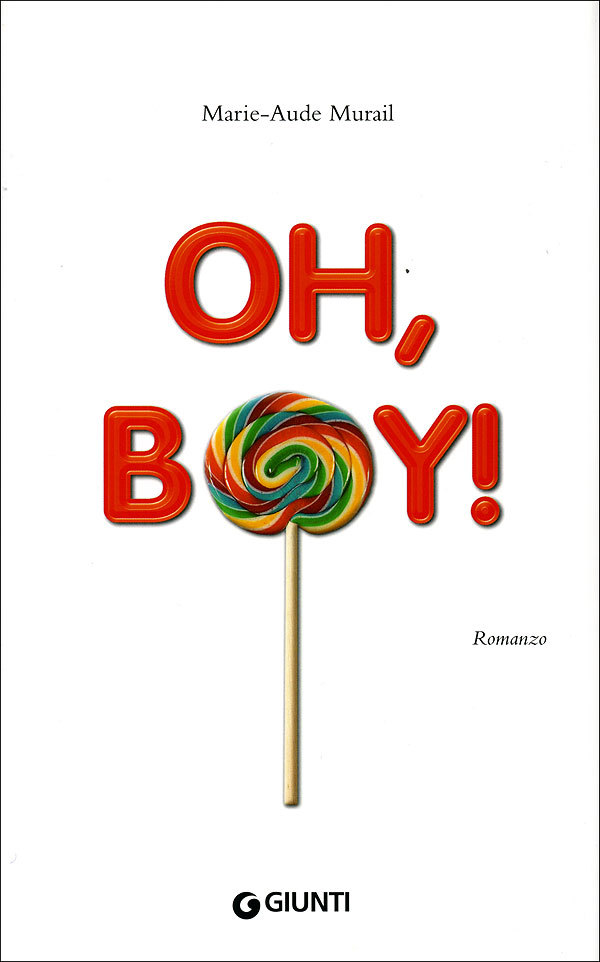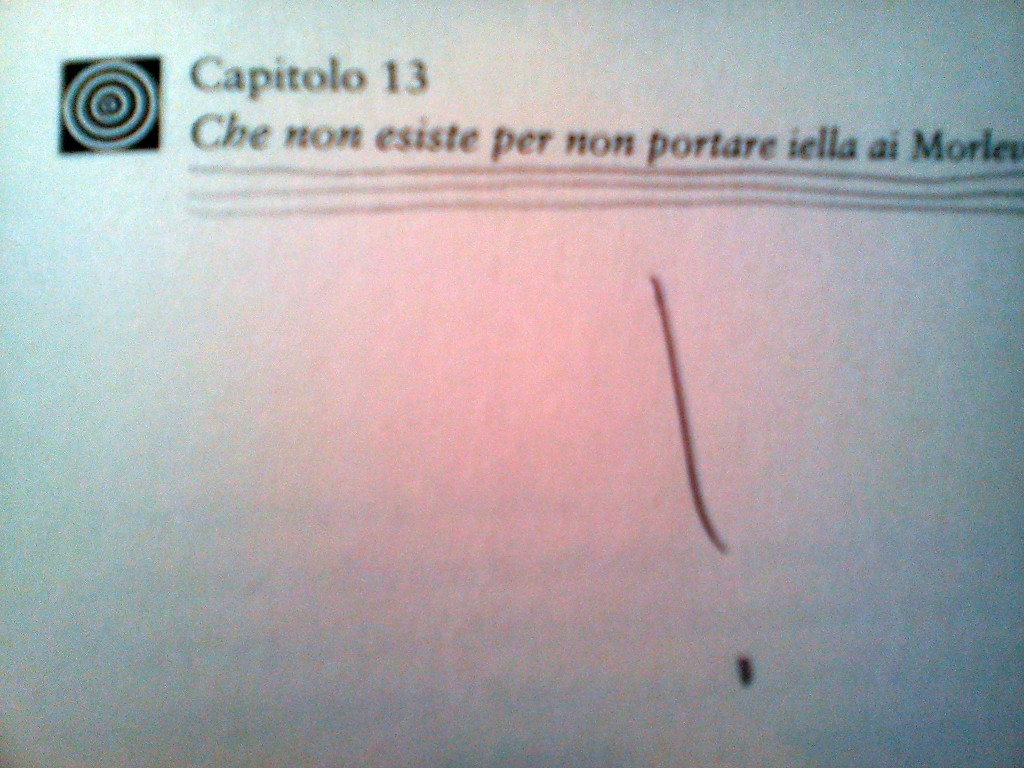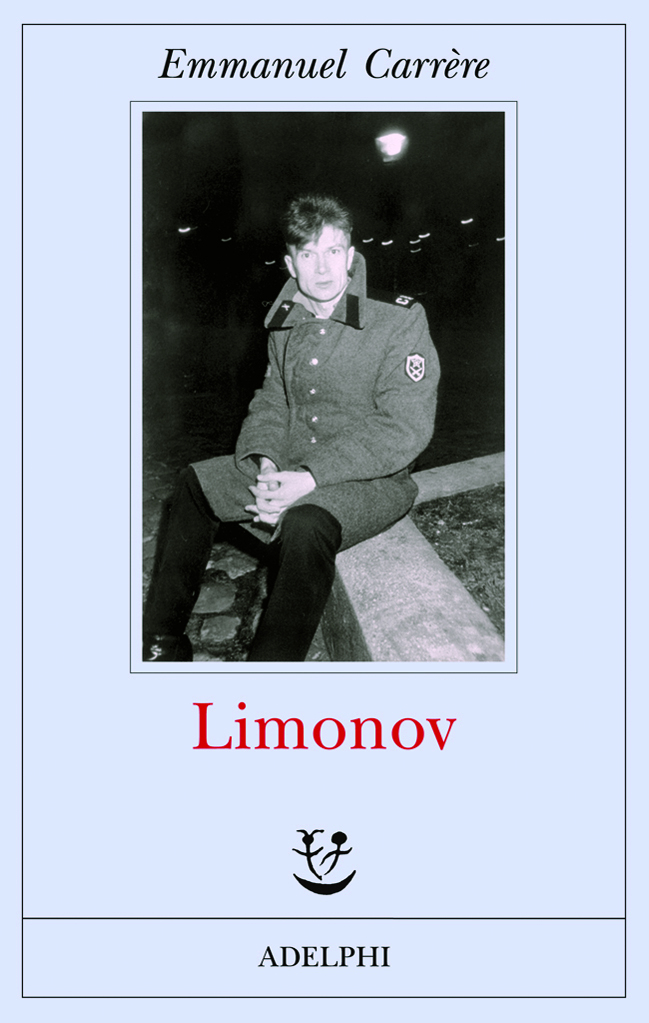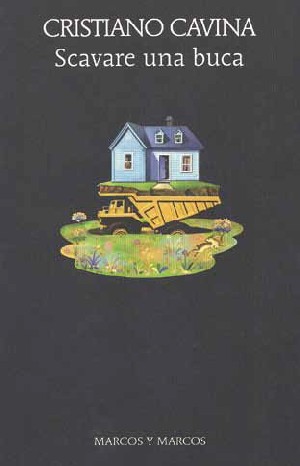Cara Scarlett Johansson,
qualche giorno fa ho finito il romanzo di Grégoire Delacourt che ti ha fatta molto arrabbiare, o forse ha fatto molto arrabbiare i tuoi avvocati e coloro che si occupano della tua immagine.
La causa intentata verso l’editore francese del libro si è conclusa in tuo favore, nonostante la cifra del risarcimento che ti verrà corrisposto sia decisamente ridicola: 2.500 euro. Non ti accuso certo di aver voluto monetizzare la faccenda, lungi da me, e ti credo invece affezionata alla sottostante controversa questione di principio. Uno scrittore ha preso la tua vita, non la mia, e l’ha fatta diventare protagonista di una storia che poi prende certe sue affascinanti e autonome strade.
Io non ti conosco particolarmente bene, e i film in cui ti ho vista recitare si contano su una zampa di gallina. In Lost in Translation mi avevi colpito moltissimo, ma senza nulla voler togliere al tuo talento me l’ero spiegato più con la magia soffusa messa in piedi dalla regista e dal direttore della fotografia, con lo zampino della stessa Tokyo. A volte sei spuntata nelle chiacchiere serie e meno serie che si fanno a scuola. Mi è capitato di citarti in quanto donna ebrea, per allontanare dalle menti degli alunni qualche immagine datata e soprattutto stereotipata.
Per i ragazzini di oggi sei soprattutto l’emblema della bellezza, il paradigma della “diva”. Mica per niente l’autore di La prima cosa che guardo ha scelto te e non un’altra per il suo esperimento letterario.
Il fatto è che il romanzo gli è uscito davvero carino. Dentro ci sei tu, ma ci sono anche alcuni snodi di una dolcezza sfacciata, ci sono un sacco di dolori taglienti che si spingono molto oltre la problematica dell’ “essere/somigliare a Scarlett Johansonn”. Ci sono tematiche, nel libro, davanti alle quali anche tu, che sei tu, passi in secondo piano. C’è anche molta ironia e c’è tra i capitoli, a cucirli insieme, un’aria fresca e leggera. Leggera come l’allusione del titolo, chiaramente riferito ad una dote tua diciamo… non proprio spirituale. Una lunga scena di sesso accompagna il lettore per molte pagine verso il finale, ma sembra uscita dal genio di Jean Luc Godard: accadono molte cose su quel talamo, ma hanno più a che fare con la storia dell’arte, della letteratura e del cinema.
Ecco, arrivo al motivo di questa lettera.
Incassa i 2.500 euro. La legge è legge. Voi Star in genere devolvete in beneficienza i guadagni delle cause vinte e tu sarai impeccabile anche in questo. Poi, però: telefona a Delacourt e chiedigli di trasformare il suo romanzo nella sceneggiatura di un film. Una pellicola che altrimenti sarebbe irrealizzabile: dove la trovi un’attrice che impersoni Scarlett Johansson senza esserlo? Impossibile, finirebbe come coi i film sul ciclismo, con attori che nonostante le diete mai e poi mai avranno il fisico asciutto e spigoloso degli assi delle due ruote a pedali.
Tu, invece, saresti perfetta. Il lungometraggio risulterebbe raffinato, ma nel contempo sufficientemente pop.
Insomma, un trionfo al botteghino.
Senza contare – scusami se è poco – che ti leveresti di torno quella fastidiosa patina d’antipatia che unge le celebrità troppo permalose, trasformandola nel suo esatto contrario.

«Mia madre diceva che ero una neonata splendida. Poi una bambina incantevole. Il sindaco voleva creare un concorso di Miss solo per me. Una bambina incantevole. La cosa ha causato dei fastidi con il mio patrigno. Faccende sgradevoli. Che ti fanno venir voglia di andartene. Come Jean Seberg nella sua automobile. Poi mia madre ha smesso di trovarmi bella. Ha smesso di parlarmi. Non so che cosa ne sia stato di lei. Ho vissuto con mia zia. Setta anni fa il mondo ha scoperto il mio viso in Lost in Translation. Dal giorno in cui è uscito, il 29 agosto 2003, odio la mia faccia. La odio ogni minuto, ogni secondo. Tutte le volte che una ragazza mi guarda chiedendosi cos’ho io più di lei. Ogni volta che un tizio mi fissa e io mi domando se mi abborderà, mi toccherà, tirerà fuori un coltello, un taglierino, pretenderà un pompino o somplicemente mi chiederà un autografo. Forse solo un caffè. Soltanto un caffè. Ma non succede mai. Non è me che guarda. Non è me che reputa bella. Non sono io.
Il mio corpo è la mia prigione. Non ne uscirò mai da viva.»
Cara Scarlett,
nella speranza che tu non faccia causa anche a me (per così poco…), ti saluto e ti auguro tutto il bene possibile.